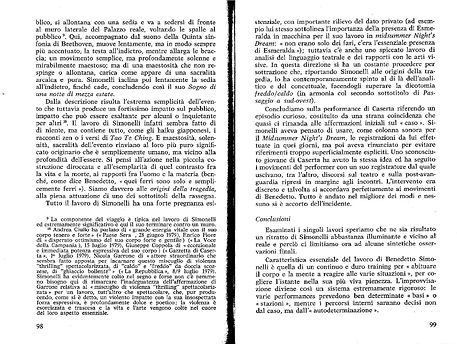ATTORE, SCRITTORE, REGISTA
“PAESE SERA” 25 maggio 1980
Barbarici e romantici
superano i californiani
Performance che Luca Ronconi e ronconiani devono vedere
di Franco Cordelli
LE REPLICHE degli spettacoli del gruppo californiano Soon 3 nella sala del Civis possono essere un pretesto per riprendere un discorso importante: quello posto a Pistoia del confronto tra teatro italiano e statunitense. Ebbene: le immagini offerte dai californiani sono queste: una asettica corsia d’ospedale, un panfilo ancorato nella baia di San Francisco, una macchina nel deserto, una piscina, un vero barbecue... O su un altro registro (e qui mi rifaccio a quanto dichiarato dal critico Michael Kirby) l’irruzione di nuovi modelli per la scena teatrale: la discoteca punk, il concerto rock, la sfilata di moda, il dramma letto invece che recitato...
Da una parte, immagini della vita del ceto medio o medio-alto; e dall’altra codici espressivi la cui maturità è stata raggiunta, forse, intorno alla metà degli anni Settanta: land-art, iper-realismo, narrative-art... Vale a dire contenuti e forme che si bilanciano e corrispondono abbastanza ragionevolmente ma che oggi, ai nostri occhi, appaiono esausti o inadeguati proprio in ragione della loro tendenza alla descrizione, alla fenomenologia, al neutro (fin quasi a fare del neutro un che di metafisico).
In questo senso, quando dichiaro la superiorità della sperimentazione italiana su quella statunitense, non credo di essere accecato, come mi è stato fatto notare, da un «complesso coloniale». Al contrario, credo che siano gli americani a non aver preso coscienza reale della propria posizione di forza apparente e debolezza reale nello scacchiere politico-culturale. Le critiche che gli Stati Uniti fanno a se stessi sembrano dettate più dagli errori per cosi dire tecnici che non da una coscienza della propria posizione morale. Forse se il blitz in Persia fosse riuscito anche il discorso teatrale risulterebbe meno distaccato. E, invece, mi sembra che gli Stati Uniti non abbiano avuto neppure il loro Kipling: mentre una specie di incandescente, sovreccitata coscienza di sé è quanto induce al controllo (poiché in arte si fa così, ci si controlla...) piuttosto che ad una messa in questione radicale di una politica o di un modo di vivere.
Esaminiamo, invece, ancora una volta, l’evoluzione della performance italiana. Possiamo considerare «Crollo nervoso» del Carrozzone (ovvero Magazzini Criminali, come si chiama ora la formazione fiorentina) come una cerniera. Lo spettacolo, costruito su un'idea di Alighiero Boetti (l’ossessione del calcolo binario), con il suo ambiente sofisticato (tutte veneziane che si alzano e si abbassano), con la sua gestualità coatta, con la sua travolgente musica (Brian Eno, cioè rock più percussione monodica), con il suo tema fantascientifico (il deserto, l’apocalisse), e con il suo elevare la sottocultura a cultura prima e assoluta (un autentico tripudio del fumetto e del cinema tipo «Alien»), lo spettacolo, dunque, indubbiamente risulta moderno e piacevole.
D’altra parte possiamo anche dire che se è accettabile la parte piacevole (perché le «opposizioni» e le «dialettiche» sono ridicole: contro quali simulacri ci opponiamo?), è meno accettabile la soluzione di mascherare la perdita d’energia (il «crollo nervoso») con le seduzioni della musica. Questa è modernità pura, cioè perdita della contemporaneità, cioè perdita del futuro. La modernità è la condanna al rispecchiamento, alla buona esecuzione del proprio «prodotto» o, al massimo, all’enfasi, al desiderio, in fondo moralistico, di presumersi o situarsi «oltre», di mettere paura. Per il Carrozzone la Scena non è un Altare né un Campo di Battaglia; ma, ancora, la Scena è la scena, qualcosa che si oppone a tutti gli altari e a tutti i campi di battaglia.
Siamo di nuovo (benché, per fortuna, in modo più elaborato) a quella particolare cecità del cuore che, negli americani, viene prodotta da una posizione di privilegio materiale e quindi psicologico. Tutto il contrario di quanto implica ogni processo artistico, vale a dire un punto di partenza «debole» (che sarà cura dell’artista di mascherare, fino a cancellarne un possibile influsso ideologico - poiché, certamente, non basta assumere la propria debolezza o emarginazione per diventare artisti!).
E abbandonarsi a se stessi, alla espressione di una presenza libera da pregiudizi ideologici o psicologici, è proprio ciò che hanno fatto Benedetto Simonelli e Andrea Ciullo nelle loro performances. Il primo, il «barbarico» Simonelli - con i suoi mucchi di carta bianca, con le sue diapositive pop e con le sue lotte e cadute - quando ha aggiunto l’elemento automobile in moto (stavolta non lavorava in cantina ma in uno spazio grande) non è cascato nella trappola catastrofica e ci ha lasciato lì, senza sacrificio e catarsi, di fronte a una immagine pura, incontaminabile da qualunque lenocinio, più come un quadro di Pollock che come un gesto di Artaud.
La performance del secondo, il «romantico» Ciullo, consisteva nell’aver reso deserta e illuminata solo da fasci sottili di luce l’enorme piazza del Duomo, con noi spettatori tutti intorno al perimetro. Una prima fase della performance prevedeva la lettura in play-back, per sette minuti, di un testo smozzicato, un po’ beckettiano. La seconda (per altri sette minuti) prevedeva una danza dello stesso performer, con un suo ormai tipico passo «manieristico», sinusoidale e sfarfalleggiante (e insomma eccentrico rispetto a qualunque lineare o prevedibile traiettoria). Niente altro. Ma avrei voluto che ci fosse Ronconi e ci fossero i ronconiani e tutti i fautori delle stupide pseudo-feste con mille sollecitazioni e un milione di persone. Per «stabilire un contatto», ad un autentico artista, magari anche, un po’ megalomane, basta molto meno...
E il fatto è - ciò che davvero ci ha colpito a Pistoia e che è emerso più nettamente proprio per la presenza degli americani - il fatto è, inoltre, che sia Simonelli sia Ciullo, in due diverse maniere, hanno di colpo invecchiato il discorse della performance fredda, finora dominante anche da noi. In fondo non hanno fatto altro che enucleare dai primi due spettacoli (gli «archetipi») del nostro teatro concettuale, «La morte di Danton» e «Autodiffamazione» di Simone Carella, il loro fondo sottilmente lirico e reimmetterlo come contenuto là dove non più compariva - negli spettacoli degli epigoni, tutti i performers freddi che hanno asfissiato la scena. Se New York è ancora la Roma del nostro tempo, una sua drammatica Atene sarà la Rossano di Ciullo, o Tivoli, che è la città dove vive e lavora Benedetto Simonelli.